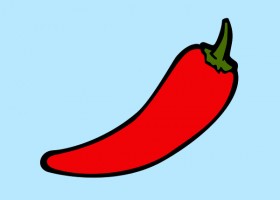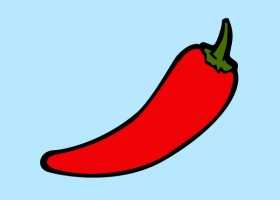
Un amico milanese mi prende bonariamente in giro per l’abitudine tutta pesarese di dire “vieni oltre”. Secondo il suo parere e quello della grammatica italiana, oltre significa al di là di un ostacolo e non al di qua. Certo ha ragione, ma la colpa è dell’abitudine, tutta pesarese, di mescolare italiano e dialetto nella stessa frase. Dovremmo prendere esempio dagli urbinati che, se anche docenti di glottologia all’università, quando sono fra di loro parlano rigorosamente in dialetto ma soprattutto non lo mescolano con la lingua di Dante e di Manzoni. Dovremmo invece dire “Ven otra” la cui traduzione non ha nulla a che fare con oltre. “Ven otra” dice il contadino al suo amico che si affaccia sulla porta. Le traduzioni dal dialetto all’italiano spesso hanno effetti curiosi, ricordiamo lo scolaro che rimproverato dalla maestra per aver usato ‘fava’ al posto di faceva scrisse in un altro tema: “Abbiamo mangiato la faceva col formaggio”. Se, come dice Umberto Eco, “tradurre significa tradire” lo è ancor di più dall’italiano al dialetto a causa della somiglianza e della confusione che crea. Odoardo Giansanti, poeta dialettale detto Pasqualon aveva compreso bene la lezione; nel suo componimento “Abbasso i critici” scriveva un verso in italiano ed uno in dialetto: “Signori gentilissimi / sti giorne aio impared / che i versi miei vernacoli / ie poch desideret / perché si stenta a leggere / ste mi dialett bsares / non tutti lo capiscono / parchè l’è mezz frances”. E ancora: “Son versi insuperabili / ma scritti in italien / a branchi abbaierebbero / listess cum baia i chen”. Da notare che il suo italiano era corretto, mentre in altri componimenti se usava frasi italiche (specie se era il cittadino che si rivolgeva al villano) utilizzava una lingua bastarda con bellissimi svarioni. Allora parliamo pure in dialetto ma evitiamo accuratamente di mescolarlo con la lingua.
ALVARO COLI